|
Anthony Molino e Roberto Carnevali Tra sogni del budda e risvegli di Freud 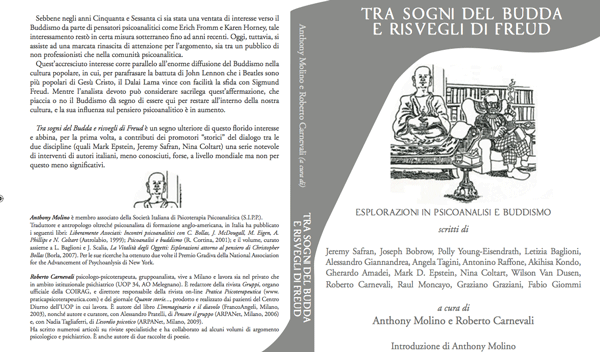 Introduzione di Anthony Molino In una recente visita al Museo Freud di Londra, ho potuto ammirare una stampa del Monte Fuji, un regalo a Freud dell’analista giapponese Heisaku Kosawa, che lo visitò a Vienna nel 1929. È accompagnato da una cartolina dello stesso Freud, che ringrazia il collega orientale “per la bellissima immagine che offre ai miei occhi una vista di cui ho letto tanto, ma che a me personalmente non è stata concessa.” Più o meno allo stesso tempo, Freud scriveva con un certo rammarico all’amica Marie Bonaparte, alla vigilia di un sua partenza per l’Oriente, che lui ormai era “paralizzato per i viaggi”. Tutto questo quando, dietro al famoso divano dei suoi pazienti, in una posizione relativamente privilegiata tra le innumerevoli antichità collezionate negli anni, già sedeva un Budda. Come documenta Janine Burke in un suo libro intitolato The Gods of Freud (Knopf, 2006), la piccola scultura era stato acquistata da Freud nel 1909 a New York, da Tiffany & Co., dopo una visita al Museo Metropolitan, durante il viaggio oltreoceano che l’aveva portato, assieme a Jung, Ferenczi e Jones, alla Clark University, vicino a Boston. Più tardi, negli anni ’30, crebbe l’interesse di Freud per l’arte orientale, al punto che arricchì la sua collezione con non pochi pezzi cinesi. Tra questi, disposta sulla sua scrivania affastellata, la statuina in bronzo del periodo della dinastia Ming, che lui affettuosamente chiamava “il prete sorridente”. Probabile effigie di un immortale taoista, ci racconta, forse, di un viaggio immaginario, fantasticato ma impossibile, per l’ebreo erede di una tradizione iconoclasta che ogni giorno scambiava, con le piccole divinità preposte alla sua protezione, sguardi di intrigante complicità… *** Da quando, anni fa, pubblicai negli Stati Uniti l’antologia The Couch and the Tree: Dialogues in Psychoanalysis and Buddhism, ho pensato spesso che non avrei dovuto essere io a curare un simile libro. Questo pensiero si rafforzò molto negli anni, man mano che il libro godeva di un discreto successo e veniva tradotto in altre lingue, tra cui l’italiano. Cominciavano, di conseguenza, a susseguirsi presentazioni, interviste e inviti a convegni per parlare del rapporto tra psicoanalisi e buddismo. Queste occasioni, pur gratificandomi, mi costringevano di volta in volta quasi a scusarmi con il pubblico convenuto per il fatto di non essere buddista e di non avere esperienza di meditazione. Invariabilmente, coglievo sempre un pizzico di perplessità, se non addirittura di delusione, fra coloro che erano venuti con entusiasmo e sana curiosità ad ascoltare il presunto profondo conoscitore della materia. Non avrei dovuto meravigliarmi, quindi, quando mi è stato chiesto se volevo curare un nuovo libro, questa volta per un editore italiano, su psicoanalisi e buddismo. Oramai la veste dell’“esperto” mi era stata cucita addosso, e non potevo non venire identificato con il soggetto che avrebbe dovuto, giocoforza, indossarla. Viene riportato come talora, solo sul finire della propria analisi, il paziente scopra la motivazione autentica che lo aveva sospinto, anni prima, a sdraiarsi sul lettino. Allo stesso modo, soltanto ora che questo libro è pronto per essere dato alle stampe, capisco le ragioni per cui accettai di curarlo. Nella versione originale de The Couch and the Tree c’è un mio saggio, da me escluso dalla versione italiana del libro, dove azzardo dei parallelismi tra il buddismo zen e il modello psicoanalitico di Jacques Lacan. Ambedue operano, notavo, sulla base di una critica feroce dell’io, e delle risultanti identità a cui siamo testardamente fedeli, o tristemente attaccati. Lacan, poi, nella sua concezione del transfert (il meccanismo inconscio per cui l’analista viene riconfigurato nella mente e nell’esperienza del paziente, sul calco psichico di figure familiari), parla dell’analista come del “soggetto che si suppone sappia”. A questo punto il lettore capirà, forse, come la cura di questo libro – e la stesura di queste stesse note – mi offrissero la paradossale possibilità di tentare di strapparmi di dosso quella veste in cui mi sentivo ingabbiato: questo, pur nel momento stesso in cui al lettore potevo lasciare supporre, indossandola, di sapere cosa stessi per dire. Scriveva Antonio Porta, in una delle mie poesie preferite: Ti rispondo ridendo: io mi chiamo Nessuno e abito non so dove e dico non so che cosa. *** La principale novità di questo libro, rispetto al mio precedente Psicoanalisi e buddismo (versione italiana de The Couch and the Tree, R. Cortina, 2001), è data dalla nutrita presenza di colleghi italiani, molti dei quali praticanti buddisti che si immergono quotidianamente nelle acque di ambedue le discipline. Ho attinto alla fonte della loro amicizia, e del loro sapere, per offrire un saggio della fiorente attenzione prestata oggi, in Italia, alle rigogliose intersezioni tra psicoanalisi e buddismo. Altri amici, prevalentemente americani, impegnati da molti anni a promuovere questo fertile confronto interdisciplinare, e che avevano già collaborato quasi tutti al primo volume, hanno contribuito generosamente a questo progetto. Tra questi Jeremy Safran, conosciuto a Milano qualche anno fa in occasione di un convegno promosso dalla Associazione di Studi Psicoanalitici sui rapporti fra psicoanalisi e buddismo (dove eravamo entrambi relatori, e dove io vivevo il mio solito disagio). Safran aveva già scritto e pubblicato in inglese, in un suo libro intitolato – udite udite! – Psychoanalysis and Buddhism, un saggio che ritengo fra i più esaurienti, perspicaci e ricchi sul tema. Non esiste, credo, panoramica migliore del suo “Psicoanalisi e buddismo come istituzioni culturali” per avvicinare il lettore italiano al dialogo fra queste due discipline. Per il suo notevole spessore, quindi, ho ritenuto opportuno che “occupasse” da solo tutta la prima parte del libro. Il resto del libro è suddiviso in tre sezioni i cui “perimetri”, se vogliamo, sono necessariamente funzionali al progetto-libro ma non per questo fissi, o statici. È chiaro, per esempio, che il tema della mindfulness, oggi portante nell’ambito del rapporto tra pratica terapeutica e buddismo (e che struttura la seconda parte del libro), non può essere scisso da quello della meditazione (cui è dedicata la terza sezione). Ugualmente, invito a ritenere le altre sezioni – rispettivamente intitolate “Mente, coscienza, consapevolezza”, “Meditazione e psicoanalisi”, e “Sinergie” – del tutto “permeabili”. Nella prima di queste, accanto alle indagini, a loro modo complementari, sulla consapevolezza, di Joseph Bobrow e degli italiani Giannandrea, Tagini e Raffone (che riportano, tra l’altro, i resoconti esperienziali di alcuni monaci dediti alla meditazione Vipassana), troviamo due saggi all’apparenza molto diversi fra loro: uno, della junghiana Polly Young-Eisendrath, che esplica in modo mirabilmente chiaro il concetto del non-sè, concetto irrinunciabile per una qualsiasi comprensione della psicologia buddista; l’altro, di Letizia Baglioni, che si addentra nell’epistemologia buddista per operarne una critica che mira ad essere ancor più che costruttiva, amorevole, laddove si cimenta addirittura con la figura storica di Gotama. Presi nel loro insieme, questi quattro lavori vogliono tracciare – attraverso strumenti quali l’intervista, il racconto autobiografico, l’aneddoto clinico, e alcuni essenziali cenni teorici – una prima sintesi dei sempre più innumerevoli sconfinamenti che animano la tensione fra questi due saperi. Nella terza sezione, “Meditazione e psicoanalisi”, figurano due fra i nomi più noti a chi frequenta il dialogo, ormai quasi secolare, fra psicoanalisi e buddismo. Il primo è Mark Epstein, autore conosciuto anche in Italia, che forse più di chiunque altro ha operato in questi anni per disseminare, anche fuori della cerchia degli addetti ai lavori, i frutti delle proprie ricerche e della propria esperienza di analista e praticante buddista. Con il suo lavoro sull’attenzione fluttuante Epstein risponde, in un certo qual modo, all’appello di Gherardo Amadei il quale, in “Quel che ci chiedono le emozioni”, insiste vigorosamente proprio sulla dimensione – cruciale sia per lo psicoanalista che per il meditante – dell’attenzione. Amadei cita in questo contesto l’opera maestra dell’altro nome che vorrei sottolineare, quello della defunta ma mai dimenticata Nina Coltart (1927-1997). Emerita analista britannica, fu fra i primi a sfidare l’ortodossia psicoanalitica e a contaminarne la letteratura con la propria esperienza pluri-decennale di buddista. Di lei, poco conosciuta in Italia, in questa raccolta siamo onorati di ospitare un discorso, tenuto nel 1986, da cui qualche anno più tardi avrebbe estrapolato, in forma ridotta e priva di cenni autobiografici, un capitolo del suo libro più famoso, intitolato Slouching Towards Bethlehem. Sarà interessante, nonché proficuo, credo, per il lettore, raffrontare le sue riflessioni sul ruolo della meditazione in psicoanalisi con quelle di Akihisa Kondo, un analista giapponese trapiantato negli U.S.A. nel secondo dopoguerra. Il suo articolo, un piccolo gioiello scritto nel lontano 1958, è stato ripescato per l’occasione dopo la sua esclusione dalla versione italiana di The Couch and the Tree. Chiudono il libro quattro saggi molto diversi tra loro, esplorazioni singolari che, pur non intersecandosi, danno un’indicazione della fertile pluralità di voci e vertici che abitano il dialogo tra psicoanalisi e buddismo. Queste “sinergie”, come ho scelto di chiamarle – letteralmente, “azioni combinate e contemporanee, collaborazione, cooperazione di più elementi in una stessa attività…” (Vocabolario Treccani) – spaziano dalle “meditazioni” di Raul Moncayo, analista americano di origine cilena, sui floridi intrecci tra psicoanalisi lacaniana e buddismo zen, all’esercizio quasi archeologico dell’italiano Graziano Graziani, che nel suo saggio “Attualità di un ospite inatteso” dissotterra l’eredità di uno dei padri fondatori della psicoanalisi italiana, Emilio Servadio, onde scoprirne i sorprendenti e sottaciuti legami col buddismo. A queste esplorazioni si aggiunge quella, ardita, dell’americano Wilson Van Dusen, sconosciuto pioniere del dialogo tra psicoanalisi e buddismo, che s’inoltra nei buchi neri della schizofrenia per sondarne l’esperienza del vuoto, che riaggancia ed àncora alla filosofia orientale (saggio pubblicato anch’esso nel 1958, “Wu Wei, non-mente e il vuoto fertile in psicoterapia” è apparso per la prima volta nella storica rivista giapponese di Kyoto, Psychologia, prima di essere da me ripreso in The Couch and the Tree.) Completa questa sezione la ricerca del mio co-curatore Roberto Carnevali, che rivisita i contributi di alcuni grandi del passato quali Erich Fromm e Takeo Doi, per rileggerli alla luce del concetto giapponese di amae. Di questa voce, intraducibile in italiano e troppo spesso resa come “dipendenza” (con tutti i connotati negativi che ha questa parola per noi occidentali), Carnevali elabora e amplifica i significati per arrivare ad una lettura clinico-socio-pedagogica che ne coglie sia la potenzialità relazionale che i nessi più profondi col pensiero buddista. *** Ho parlato, sino a questo momento, molto poco di psicoanalisi, e ancor meno, forse, di buddismo. L’ho fatto di proposito, tenendo ben presenti i versi di Porta che ho citato poco fa, e volendo che sia il libro, e le straordinarie voci che lo compongono, a far giungere al lettore “il suono del battito di una mano” assieme agli echi del “conosciuto non pensato”. E proprio a questo fine vorrei evocare due mie letture recenti, nonchè qualche commento del cantautore canadese Leonard Cohen (tratto dal cd di un suo sublime concerto dal vivo). Lo faccio… così, in un esercizio apparentemente senza capo né coda, ma destinato a quel “terzo orecchio” celebrato da Theodor Reik e di cui, sono convinto, siamo tutti dotati. Sai, il termine che il Buddha usa, “L’illuminato” o “Il risvegliato”, cosa vuol dire? Perché lo usa? Perché noi viviamo dormendo. Durante tutta lo nostra vita dormiamo. Dormiamo con la nostra coscienza con cui non traffichiamo, dormiamo con la nostra mente che usiamo solo per fare i conti e per fregare i clienti dell’azienda per la quale lavoriamo. Poi passa uno che dice, “Svegliati!” Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio Principio dei principi, causa prima, Dio non può essere raccontato se non col vocabolo “nulla”. Lo si designa con la frase: Colui che crea dal nulla. In ebraico il vocabolo ain (nulla) evoca il vocabolo anì (io). Come noi, molto confusamente, Lo si concepisce, sarebbe Dio il nulla personalizzato?… Nella nostra miserevole lontananza, parliamo dell’Inesprimibile dicendo El (dio). El è Dio nella Sua potenza, ma, se rovesciamo il vocabolo, che cosa abbiamo? Abbiamo lo (no): la negazione… Carlo Coccioli, Davide Nell’album Live in London del 2009, Leonard Cohen dà un’interpretazione magistrale, infusa di generosa auto-ironia, di una delle sue canzoni più belle, “Tower of Song”. La canzone, della durata di oltre sette minuti, è impreziosita da un accattivante ritornello senza senso ripreso più volte, con delicate e suadenti armonie, dal gruppo delle coriste. Il verso, molto semplice, fa così: DU DUM DUM DUM DU DU DUM DUM Verso la fine della canzone, in dialogo serioso con la marea di gente che aveva inondato a Londra la O2 Arena, l’affabulatore confessa con signorile imbarazzo di essere approdato da poco alla riva del mistero dei misteri, di aver penetrato proprio nel corso del concerto il nucleo essenziale di tutte le cose. Persona troppo perbene e altruista da voler tenere per sé questa rara perla di saggezza, chiede giocosamente al pubblico se vuole esserne reso compartecipe. All’urlo roboante di assenso che sale dalla platea, Cohen esita, seduce con la sua finta timidezza, tentenna. Poi, beffardo, dice: “Volete sapere la risposta? Avete davvero fame per la risposta? Bene, perché siete proprio il tipo di persone a cui la direi…” E nel silenzio che segue, con voce greve e dolcemente roca, rivela: “La risposta a tutti i misteri è… DU DUM DUM DUM DU DU DUM DUM.” Ragion per cui mi associo al monaco e al clown, al biblico re d’Israele come al poeta dei nostri giorni, e dico: “Ti rispondo ridendo: io mi chiamo Nessuno/e abito non so dove e dico non so che cosa”. Buona lettura, tra sogni del Budda e risvegli di Freud. *** Vorrei ringraziare indistintamente tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto. Un ringraziamento particolare va a Jeremy Safran e la sua casa editrice americana, Wisdom Publications, per aver permesso la traduzione e pubblicazione in italiano del saggio “Psychoanalysis and Buddhism as Cultural Institutions”, tratto dal libro dello stesso Safran intitolato Psychoanalysis and Buddhism: An Unfolding Dialogue (Boston, 2003). Un simile ringraziamento va a Mark Epstein e alla rivista The Journal of Transpersonal Psychology per l’uso concesso dell’articolo “On the Neglect of Evenly Suspended Attention”, apparso originariamente sulla stessa rivista nel 1984 (vol. 16, n. 2); nonché a Joseph Bobrow e alla rivista International Journal of Applied Psychoanalytic Studies per l’articolo “A Presence of Mind”, apparso sulla medesima rivista in un numero unico del 2004. Come ho già indicato, i saggi di Akihisa Kondo e Wilson Van Dusen, ambedue pubblicati per la prima volta nel 1958, sono ripresi dal mio The Couch and the Tree: Dialogues in Psychoanalysis and Buddhism (New York: North Point Press, 1998). L’articolo di Kondo è apparso originariamente sulla rivista Chicago Review (vol. 12, n. 2, pagine 57-64), mentre quello di Van Dusen su Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient (vol. 1, pp. 253-256). Unico contributo al volume già pubblicato in Italia, la traduzione del saggio di Van Dusen, ad opera di Letizia Baglioni, è ripresa dal libro di John Welwood L’incontro delle vie: un’esplorazione della psicologia orientale/occidentale. Appare qui per gentile concessione del direttore della casa editrice Astrolabio-Ubaldini, Francesco Gana. Il discorso che Nina Coltart tenne il 25 ottobre 1986, intitolato “The Practice of Buddhism and Psycho-Analysis and How Meditation Plays Its Part”, appare in traduzione per la gentile concessione di Gill Preston, sorella nonché erede della dottoressa Coltart. Purtroppo né io né la signora Preston siamo riusciti a risalire al luogo dove la Coltart presentò il lavoro nella versione originale. Il dattiloscritto, però, riporta la dicitura, scritta a mano: “talk given Oct. 25, 1986”. Infine, questo libro deve la sua esistenza a cinque persone che meritano una citazione speciale: al mio collega-curatore Roberto Carnevali, all’editore di ARPANet Paco Simone, a Letizia Baglioni, e alle traduttrici Elena Ferrari e Annamaria Sferruzza. Senza il prezioso e distinto contributo di ciascuno di loro, il battito della sola mia mano risulterebbe del tutto impercettibile.
Indice Anthony Molino Nota dei curatori » 17 PARTE I: Psicoanalisi e buddismo come istituzioni culturali » 19 Jeremy Safran PARTE II: Mente, coscienza, consapevolezza » 57 Joseph Bobrow Polly Young-Eisendrath Letizia Baglioni Alessandro Giannandrea, Angela Tagini, Antonino Raffone PARTE III: Meditazione e psicoanalisi » 135 Akihisa Kondo Gherardo Amadei Mark D. Epstein Nina Coltart PARTE IV: Sinergie » 187 Wilson Van Dusen Roberto Carnevali Raul Moncayo Graziano Graziani Fabio Giommi Note biografiche » 243
|